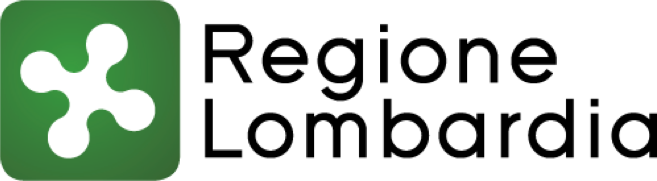-
Approfondimenti
“Doppi trapianti e staminali: così abbiamo cambiato la vita dei malati di insufficienza renale”
Il bergamasco Remuzzi, giurato del premio “Lombardia è ricerca”: per sostenere la scienza nelle scuole si insegni ad avere spirito critico”
di Redazione Open Innovation | 16/10/2017
Doppi trapianti, ricorso alle cellule staminali, farmaci innovativi: è una lotta a tutto campo contro le patologie renali quella che da oltre 35 anni conduce il professor Giuseppe Remuzzi, uno dei 14 top scientists chiamati da Regione Lombardia nella giuria del nuovo premio internazionale “Lombardia è ricerca”, che verrà consegnato a Giacomo Rizzolatti la mattina dell’8 novembre al Teatro alla Scala di Milano.
La sua è una carriera medica tutta votata alla ricerca, dalla specializzazione a Milano alla guida dell’Unità di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Docente del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano, Remuzzi è poi coordinatore delle Ricerche dell’Istituto Mario Negri Bergamo e dal 1992 di uno dei più importanti centri per le Malattie Rare, l’‘Aldo e Cele Daccò’ di Ranica. Remuzzi ricorda il grande (e sottovalutato) impatto delle malattie renali sulla popolazione mondiale. Già presidente dell’International Society of Nephrology (ISN), ha lanciato il progetto “0by25” per azzerare il numero di morti da insufficienza renale acuta nei paesi poveri entro il 2025: oggi sono 1 milione e 700 mila ogni anno (tanti quanti quelli da AIDS). Mentre in Italia dopo qualche settimana di dialisi, si torna a una vita normale.
Professore, anzitutto quali sono oggi i numeri dell’insufficienza renale, e in che percentuale questa è mortale?
“Le stime parlano di circa 500 milioni di persone nel mondo con una qualche forma di insufficienza renale, di questi un 10% soffre di una forma cronica e necessita di dialisi (per ripulire il sangue vicariando la funzione del rene grazie ad apparecchi medici, ndr) o di sostituire il rene malato attraverso un trapianto. Quando ho iniziato, la sopravvivenza degli ammalati in dialisi era di pochi anni, ora si può convivere con questo trattamento anche per quarant’anni. E nel mondo oggi sono 2 milioni le persone che vivono grazie alla dialisi: si trovano però per il 90% negli Stati Uniti, in Europa, in Giappone e in Australia. Negli altri paesi in cui questo trattamento non è disponibile succede invece che ogni anno muoiano per problemi renali più persone di quante non ne uccidano nel complesso tubercolosi, malaria e AIDS. Eppure nessuno lo sa. In Italia non c’è questo tipo di mortalità, rimane il fatto che la vita in dialisi è molto pesante, con sedute di quattro ore tre volte la settimana, per sempre”.
Come ha indirizzato le sue ricerche?
“Nei miei primi anni di attività ricordo la dialisi come un girone infernale, con i pazienti che collassavano durante il trattamento, i trapianti che andavano male, i farmaci con effetti collaterali così pesanti da essere certe volte peggio della malattia. Da medico dunque ho voluto cercare una soluzione a queste sofferenze con un percorso che se vogliamo è stato l’opposto di quello tradizionale: vedevamo (i miei colleghi e io) i problemi dei pazienti, e ci facevamo aiutare dalla ricerca scientifica per risolverli, poi tornavamo ai pazienti per validare i risultati. Il nostro problema era riuscire a evitare il più possibile l’evoluzione delle malattie renali in insufficienza renali, così da limitare il numero di persone costrette alla dialisi. Ci siamo riusciti, e lo abbiamo dimostrato con lo studio REIN, pubblicato su Lancet, in cui si evidenziava l’efficacia di alcuni farmaci, solitamente usati per abbassare la pressione, nel rallentare e in alcuni casi arrestare la progressione del danno renale, evitando la dialisi, in determinate nefropatie croniche. Un altro studio importantissimo è stato quello sul diabete, BENEDICT. La premessa è che il 30% dei pazienti diabetici sviluppa una malattia renale, e che tra questi ultimi casi si sviluppano complicanze cardiache mortali. Noi abbiamo dimostrato che nel diabetico è possibile prevenire il danno renale e quello, conseguente, cardiovascolare. Sono seguiti altri studi, e il merito è tutto delle persone che lavorano con me”.
Avete fatto scuola anche sui trapianti, ci racconta come?
“Quando la malattia non poteva essere rallentata e si doveva ricorrere al trapianto si presentavano due problemi: il basso numero di reni disponibili alla donazione e il rigetto. Sul primo fronte, quando siamo partiti la prassi prevedeva di scartare tutti i donatori over 50, c’erano però ancora molte morti e dunque molti donatori tra i giovani, anche per un più alto numero di incidenti stradali. Per fortuna queste morti sono diminuite, e allora abbiamo cominciato a verificare la possibilità di trapiantare organi di donatori anziani fino all’idea di utilizzare i due reni di un donatore per lo stesso ricevente – ne ha scritto anche il New York Times - dopo aver effettuato una biopsia per accertare con precisione lo stato di “salute” di quei reni. Il nostro ultimo studio, che è stato pubblicato sull’American Journal Transplantation proprio in questi giorni, mostra come si possano utilizzare anche reni di persone ultraottantenni. Una novità che rappresenta un cambio completo di prospettiva, specie negli USA dove non è mai stato tentato in uno studio controllato: per una volta, possiamo dire che siamo più avanti degli americani”.
E per quel che riguarda il rigetto degli organi?
“Siamo riusciti ad aumentare la tollerabilità del rene trapiantato nei topi ‘ingannando’ il timo (dove nascono i globuli bianchi responsabili del rigetto ndr). Nell’uomo è più complicato e allora abbiamo puntato sulle staminali per controllare la risposta immunitaria. Si tratta di una strada su cui procediamo con prudenza: dopo i primi due pazienti abbiamo imparato qual è il tempo di somministrazione delle cellule staminali, lo abbiamo verificato sui topi, abbiamo cambiato il protocollo per altri due pazienti. Alla fine siamo arrivati a cinque pazienti, concludendo che non c’erano pericoli. Non solo, si è creato un ambiente di tolleranza intorno al rene trapiantato così l’ultimo paziente ha potuto ridurre i farmaci antirigetto al punto che oggi è in terapia con un solo farmaco a un dosaggio bassissimo, un caso quasi unico. Crediamo quindi di essere sulla strada giusta”.
Poi ha incrociato la genetica…
“Lavoriamo per trovare i geni che si associano ad alcune malattie renali di cui ci occupiamo molto, come la più grave che possa colpire i bambini, la sindrome Emolitico Uremica di origine genetica, una patologia che fino a non molto tempo fa portava alla morte - o alla necessità di dialisi - dei piccoli entro sei anni dalla diagnosi e per la quale ora sono stati trovati dei farmaci. Presto avremo dei farmaci anche per le altre malattie del complemento, rimane però il problema del loro costo: un farmaco che protegge i bambini dalla sindrome Emolitico Uremica costa 330 mila euro per un anno di trattamento, un prezzo oltraggioso, stiamo lavorando ad accordi che permettano di ridurlo. Inoltre abbiamo messo a punto un test per capire quale sia la posologia effettivamente necessaria a seconda delle condizioni del paziente, in modo da diradare la somministrazione di un farmaco tanto caro e di rinviarla anche di alcuni mesi”.
Lei che ha sempre fatto ricerca lavorando nel pubblico, crede che il nostro sistema sia ancora sostenibile?
“Quello che spendiamo per questa voce è davvero pochissimo - rispetto agli USA, all’Europa e al mondo -, quindi quello che riescono a fare i ricercatori italiani secondo me ha del miracoloso. Ma non può durare così. E allora dobbiamo aumentare la sensibilità dei politici verso due problemi. Primo: lo sviluppo è legato alla ricerca, questa rappresenta l’unico modo di dare un futuro a una nazione. Tutti i Paesi che hanno superato la crisi, l’Irlanda ad esempio, l’hanno fatto investendo in ricerca anche durante la stessa crisi, mentre in Italia si ha l’atteggiamento opposto: tutte le volte che l’economia è in difficoltà si taglia sulla ricerca, ai nostri politici manca la visione necessaria. Secondo punto, i giovani: ogni anno se ne vanno tra i 30 e i 40 mila ragazzi, quasi nessuno torna e quello che abbiamo speso per formarli – 3 miliardi di euro – viene buttato. Una follia, è incredibile che chi ha responsabilità di fare piani di sviluppo non lo colga”.
Come e da dove si riparte?
“Occorre parlare il più possibile della centralità della ricerca. Il nuovo premio di Regione Lombardia è un modo per farlo. Bisogna poi sperare che chi ci governi in futuro abbia una formazione adatta a comprendere quanto è preziosa la ricerca scientifica: se non sarà così, se non avremo governanti con abbastanza esperienza di questa realtà non vedo possibilità di cambiare le cose. Occorrerebbe anche intervenire per formare una sensibilità scientifica fin dalla scuola: purtroppo questa in Italia ha ancora un impianto più centrato sulle materie umanistiche, vorrei si capisse che non c’è nulla di più umanistico che occuparsi della salute dell’uomo e del futuro dell’umanità. E che questo futuro dipende interamente dalla scienza: basti pensare alla più importante emergenza che dovremo affrontare nel giro di trent’anni, ovvero il riscaldamento globale da cui deriveranno malattie, migrazioni, morti. Papa Francesco lo sa bene: nella sua Laudato Sì sulla protezione del creato ed esorta ad ascoltare gli scienziati e a investire in ricerca. Questo dovremmo insegnare nelle scuole. Inutile combattere le fake news sulla rete, dove qualunque opinione conta come quella di uno scienziato: meglio investire sulla formazione di uno spirito critico nelle nuove generazioni, perché sappiano smentire da sé chi nega l’utilità dei vaccini o i pericoli dei cambiamenti climatici”.
La sua valutazione del premio “Lombardia è ricerca”?
“Un bellissimo esempio di attenzione verso la ricerca e i suoi campioni, sarebbe fantastico se la Lombardia venisse imitata da altre Regioni. Ho apprezzato anche che il 70% di un premio così cospicuo vada a finanziare ricerche sul territorio coinvolgendo molti giovani, e contribuendo così a rendere la Lombardia ancora più forte in un settore in cui già eccelle. Abbiamo lavorato con passione e direi con efficienza, non era facile – le tre candidature finali erano tutte fortissime – ma la scelta di una figura di altissimo profilo come quella di Rizzolatti ha messo tutti d’accordo”.
Vuoi essere sempre aggiornato?
Partecipa attivamente, accedi a Open Innovation