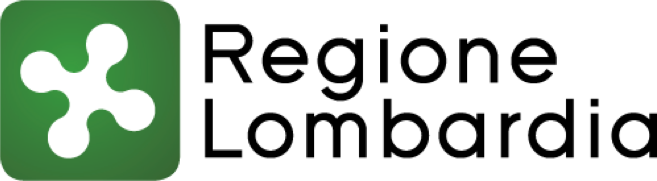-
Storie di innovazione
Detriti cosmici, ecco gli “spazzini” Made in Italy
Prevista per la mattina di Pasqua la caduta sulla Terra dei rottami della stazione spaziale cinese Tiangong-1: sempre più urgente capire come eliminare ciò che rimane dei satelliti in orbita
di Redazione Open Innovation | 29/03/2018
Da qualche settimana gli occhi di centinaia di persone sono puntanti sullo spazio, in attesa della caduta della stazione spaziale cinese Tiangong-1 da un’altezza di 350 chilometri dal suolo. Quando mancano meno di tre giorni all’evento, si restringe la finestra di rientro nell’atmosfera - le ultime previsioni indicano che potrebbe avvenire la mattina di Pasqua sull’Asia, tra le 4 e le 8.30 (ora italiana) e alcuni dei rottami potrebbero precipitare anche sull’Italia meridionale. L’evolversi della situazione è monitorato da diversi centri, che hanno fornito anche indicazioni pratiche ai cittadini (restare al chiuso e lontano dalle finestre nelle zone interessate alla caduta dei detriti).
Una situazione di allarme che potrebbe diventare abituale in futuro. E su cui promettono di intervenire i nuovi “spazzini cosmici”, in grado di rimuovere i rottami spaziali dall’orbita della Terra e di risolvere il problema della pioggia di detriti proveniente dall’esplosione di satelliti destinata a ricadere sul globo terrestre. Sono diverse le realtà, tra cui molte italiane, pronte a inserirsi in un settore potenzialmente in grande sviluppo: quello della “pulizia aerospaziale” rimane un problema da affrontare, sfruttando le più moderne tecnologie e cercando di contenere i costi.
L’INQUINAMENTO NELLO SPAZIO
Sono centinaia di migliaia gli oggetti che orbitano intorno alla Terra in maniera incontrollata: satelliti ormai non funzionanti (anche micro satelliti, messi facilmente in orbita da privati, oggetti da 10 a 100 chilogrammi di peso), frammenti, parti di razzi ormai inutilizzati. Secondo la rete Usa Space Surveillance, nello Spazio circolano 29 mila oggetti più grandi di 10 centimetri. La stessa Stazione Spaziale internazionale (ISS), grande come due campi di calcio, deve spostare la sua traiettoria una o due volte l’anno per evitare scontri che metterebbero a rischio la vita degli astronauti. Risolvere completamente il problema non sembra possibile con le tecnologie attualmente a disposizione, ma è possibile mitigarlo e contenerlo.
PULIZIA AEROSPAZIALE “MADE IN ITALY”
Ecco ad esempio alcune imprese italiane attive nella pulizia nello Spazio. Ora in Inghilterra, ma laureato al Politecnico di Milano, Guglielmo Aglietti è il “padre” del primo sistema per la pulizia dell’orbita della Terra, RemoveDebris, progetto finanziato per metà dalla Commissione Europea. Grazie al collaudo di diverse tecnologie, il veivolo cosmico messo a punto mira a eliminare almeno i detriti più pericolosi: una sperimentazione prevista proprio da marzo di quest’anno. Come funziona? Il satellite RemoveDebris ha il compito di collaudare un sistema di visione laser dotato di software intelligente, con cui valutare movimenti e velocità del rottame prima di intervenire. Quindi di lanciare un arpione per agganciare un obiettivo e dispiegare una vela solare che, rallentando il RemoveDebris, ne favorirà la disintegrazione.
Di inquinamento spaziale si occupa anche la cremasca D-Orbit: il suo sistema si installa sul satellite per spingere lo spacecraft verso l’atmosfera una volta terminata la sua vita operativa, impedendogli di precipitare naturalmente dopo aver orbitato senza controllo per un periodo indefinito. Il satellite si distrugge subito e non crea altri detriti. D-Ordit si presenta infatti come un piccolo modulo aggiuntivo al corpo del satellite, che può essere attivato a distanza: il motore fornisce un impulso ed ecco che il satellite viene riportato verso terra nel modo voluto e va a disintegrarsi nel contatto con l’atmosfera, facendo cadere i detriti in zone sicure. Il sistema è già stato provato in orbita e la sua funzione è quella di non creare ulteriore ‘spazzatura’ spaziale.
Ma come sapere dove cadono i frammenti derivanti dall’esplosione e che cosa succede durante la loro discesa verso il suolo? A questo problema sta lavorando una start up milanese, Aviosonic Space Tech. Il suo prodotto consiste in un piccolo guscio, che si aggiunge al satellite o al razzo vettore e si attiva nel momento dell’esplosione al rientro in atmosfera diventando, a sua volta, un frammento “smart”. Inizia così la discesa della nuvola di frammenti-proiettili sorvegliata però dallo smart fragment, che continuamente ne calcola la posizione trasmettendo informazioni in tempo reale e fornendo anche sofisticati modelli dell’atmosfera terrestre.
Una delle poche realtà al mondo a operare in modo specifico nel mercato dei micro-satelliti, anche se su un fronte diverso, è infine Leaf Space, vera e propria eccellenza lombarda che prima ha conquistato i fondi del programma Horizon 2020, 50mila euro, per poi avvicinarsi al mercato. Il suo progetto consiste in una rete di “ascolto”, in grado di fornire servizi innovativi ed efficienti nella raccolta dei dati a terra: un modo si prolungano le finestre di tempo utilizzabili per l’acquisizione dei dati e si migliora l’efficienza di questi strumenti prolungandone la vita. Leaf Space è stata creata da tre ingegneri aerospaziali del Politecnico di Milano quindi incubata in Polihub, dove è partita l’attività, e in I3P del Politecnico di Torino, oggi invece è dislocata a Lomazzo in ComoNext.
LA CAMPAGNA DI OSSERVAZIONE DE “LA SAPIENZA” DI ROMA
Il nodo critico dei detriti spaziali attiva anche i centri ricerca. In questi giorni ad esempio i sensori ottici dell’Università La Sapienza di Roma, dislocati sul territorio nazionale, sono puntati sulla stazione spaziale cinese Tiangong-1, per osservarne il comportamento nella fase finale di rientro sulla Terra: questo permette di provare nuovi algoritmi, messi a punto dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed aerospaziale, che potranno essere utilizzati in futuro per migliorare l’accuratezza dei dati orbitali inserendo misure ottiche o radar. La campagna di osservazione ottica della Sapienza è svolta in parallelo a quelle di numerosi altri enti pubblici e privati in tutto il mondo. In Italia la responsabilità è affidata al tavolo tecnico coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile.
Vuoi essere sempre aggiornato?
Partecipa attivamente, accedi a Open Innovation