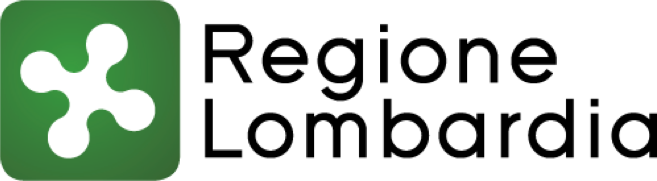-
Storie di innovazione
I 65 anni della doppia elica del Dna, icona “pop” della scienza
A fine febbraio la scoperta della struttura della molecola della vita, simbolo della biologia e del progresso scientifico, frutto della combinazione di sole quattro ‘lettere’
di Redazione Open Innovation | 28/02/2018
È il 28 febbraio 1953 il giorno in cui viene scoperta la struttura della molecola della vita: la doppia elica del Dna. Nei laboratori di Cambridge, il biologo americano James Watson e il fisico britannico Francis Crick - grazie al contributo dei biologi Maurice Wilkins e Rosalind Franklin, che per prima realizza l’immagine a raggi X del Dna – scoprono quello che sarebbe diventato il simbolo della biologia e di tutta la scienza. A fine febbraio si celebrano quindi i 65 anni di quella che è divenuta una vera icona (anche pop) della scienza.
Sono state tante le sorprese che si sono susseguite nei decenni dopo la pubblicazione sulla rivista scientifica Nature, il 25 aprile 1953, e il successivo riconoscimento con il premio Nobel per la medicina nel 1962. Fino ad allora tutti sapevano che il Dna - dall'inglese DesoxyriboNucleic Acid, in italiano acido deossiribonucleico - fosse una molecola lunghissima dalla quale passavano le informazioni genetiche, ma continuava a essere abbastanza misteriosa, specialmente nella forma e nel meccanismo di funzionamento. Nessuno era riuscito ancora a spiegare, fino a quel momento, come funzionasse l’acquisizione delle informazioni e il loro passaggio al resto della cellula.
Quasi come ogni grande “colpo di genio”, la proposta d Watson e Crick viene accolta solo qualche decennio dopo, quando vengono pubblicati altri studi scientifici, per poi trovare il più largo consenso negli anni Novanta, quando esplode il boom dell’industria genetica.
LA SCALA A CHIOCCIOLA A PIOLI
Una scala a chiocciola a pioli: questa la struttura a cui il Dna viene sempre paragonato, in cui i “montanti” sarebbero le due catene polinucleotidiche e ogni “piolo” una coppia di basi azotate (adenina, timina, citosina e guanina), ciascuna appartenente a una delle due catene polinucleotidiche. Le due basi che formano un piolo si uniscono, secondo le regole di Chargaff, tramite dei legami a idrogeno: l’adenina forma due legami idrogeno con la timina, mentre la citosina forma tre legami idrogeno con la guanina. Il Dna ha quindi un alfabeto composto da quattro “lettere” (A, T, G, C), le iniziali delle basi azotate, che si combinano in triplette per formare il codice genetico. All’interno del del Dna sono contenute le istruzioni fondamentali per sintetizzare le proteine mediante la decodifica del codice genetico.
PAROLA AGLI ESPERTI (Fonte: Ansa)
"La tappa più importante è stata sicuramente la scoperta degli enzimi di restrizione, quegli strumenti molecolari che ci permettono di tagliare e cucire il Dna per fargli fare ciò che vogliamo", spiega il genetista Giuseppe Novelli, rettore dell'Università di Roma Tor Vergata.
"La ricombinazione genetica ha segnato una svolta. Ha permesso, ad esempio, di produrre insulina umana per i diabetici usando i batteri cresciuti in laboratorio invece che i maiali, ma soprattutto ha aperto la strada alle due grandi novità del momento che cambieranno il nostro futuro: la tecnica Crispr, che ci permetterà di correggere il Dna in modo ultra preciso cancellando molte malattie genetiche, e la riprogrammazione delle cellule, che ha aperto nuovi scenari per la medicina rigenerativa mandando in soffitta l'idea della clonazione umana finalizzata alla produzione di pezzi di ricambio".
La strada sembra segnata, anche se è difficile immaginare quali sorprese ci riserverà ancora la doppia elica. "Le previsioni nella scienza sono fatte per essere smentite, perché la ricerca riesce sempre a stupirci", sottolinea Boncinelli. "Di certo, presto arriveremo a modificare il genoma della nostra stessa specie, per diventare più sani e longevi. Le tecnologie sono già disponibili: siamo noi che tentenniamo, perché con l'essere umano non si può giocare. Tutto questo comunque mi fa ben sperare, l'esito che ne avremo dipenderà da quanto giudizio ci metteremo. Noi ci siamo auto definiti Homo sapiens: ora dobbiamo dimostrare di esserlo per davvero".
Vuoi essere sempre aggiornato?
Partecipa attivamente, accedi a Open Innovation