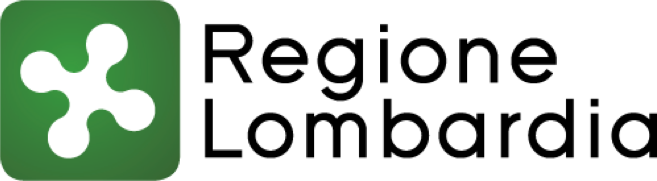-
Approfondimenti
Crespi (PoliMi): “Coronavirus e lavoro da remoto, ecco come renderlo Smart Working”
Intervista al Direttore dell’Osservatorio che monitora l’organizzazione di imprese e PA
di Redazione Open Innovation | 07/04/2020
Non è il vecchio telelavoro, né Smart Working. Il lavoro da casa in cui si sono milioni di italiani si sono trovati improvvisamente catapultati dall’emergenza Coronavirus è un ibrido ancora da indagare. Ma mette comunque l’Italia nelle condizioni di puntare in futuro a una maggiore diffusione del ‘vero’ Smart Working. Perché e in che cosa consista, lo spiega in questa intervista Fiorella Crespi, Direttore dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano che dal 2012 studia l’evoluzione del lavoro agile all’interno di aziende e Pubblica Amministrazione.
Direttore, anzitutto: perché il lavoro da casa imposto dall’epidemia non può dirsi Smart Working?
“Lo Smart Working, per come lo intendiamo, prevede la flessibilità piena nella scelta degli spazi e dei tempi di lavoro. I primi insomma possono essere diversi dall’abitazione del lavoratore, che ad esempio si può scegliere di spostarsi tra le diverse sedi dell’azienda o in uno spazio di coworking. Quest’emergenza al contrario limita lo spazio di lavoro alla casa. L’orario di lavoro poi nello Smart Working non sempre coincide con quello previsto per chi si reca in azienda. Al lavoratore è lasciata libertà di organizzarsi secondo le proprie necessità, perché la vera caratteristica dello Smart Working è puntare sulla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti: l’accento viene posto su obiettivi e risultati più che sugli orari e i luoghi della prestazione lavorativa, con un approccio quasi ‘imprenditoriale’. Lo Smart Working non è insomma un semplice telelavoro, impone un vero salto culturale e una svolta nell’organizzazione aziendale”.
"Lo Smart Working non è una semplice misura di Welfare ma un vero salto culturale, centrato su una maggiore autonomia e responsabilizzazione del lavoratore"
In cosa differisce il lavoro da casa di questi giorni, allora, dal vecchio telelavoro?
“Quest’ultimo prevedeva un semplice cambio della postazione di lavoro, che doveva essere certificata dall’azienda, ed era regolato da un contratto che ne normava tutti gli aspetti. Soprattutto, il telelavoro non contemplava necessariamente una responsabilizzazione del lavoratore. Ecco perché quello che vediamo oggi è una forma nuova e ibrida, che chiamerei ‘lavoro da remoto’. Attivata in emergenza, non prevede la revisione dei contratti: è stata usata invece una procedura semplificata, ovvero una certificazione propria del lavoro agile; le postazioni sono create all’interno dell’ambiente domestico e, talvolta, mancano le dotazioni informatiche. E, punto centrale, questo lavoro da remoto non ha potuto contare sul cambio di mentalità e di organizzazione aziendale necessario per parlare di uno Smart Working compiuto, se non nei casi in cui è stato applicato in realtà che già prima avevano sviluppato iniziative di Smart Working. Quello, appunto, che a differenza del telelavoro non attiva una semplice misura di welfare ma una nuova organizzazione del lavoro, centrata su una maggiore autonomia - di iniziativa e di giudizio, oltre che di gestione degli spazi e dei tempi - da parte del singolo rispetto al datore di lavoro”.
"Tra 2018 e 2019 gli smart worker in Italia sono cresciuti del 20%"
Quanto era diffuso il ‘vero’ Smart Working in Italia prima dell’emergenza Covid-19?
“La nostra ultima rilevazione, a ottobre 2019, indicava che il 58% delle grandi imprese (quelle con oltre 250 addetti) aveva avviato una forma strutturata di Smart Working: prevedeva cioè un accordo individuale con il lavoratore, formazione e regolamenti precisi; un 7% aveva scelto un approccio ‘informale’, in cui la definizione degli aspetti dello Smart Working veniva lasciato alla relazione tra lavoratore e il proprio responsabile. Tra le PMI invece era diffuso solo per il 12% in modo strutturato, mentre prevaleva l’approccio informale (18%). Nella Pubblica Amministrazione, nonostante fosse incentivato dalla legge di riforma della PA del 2015, si fermava al 16%, comunque in crescita rispetto all’8% del 2018”. Un’altra nostra rilevazione, fatta su un panel rappresentativo di smart worker che comprendeva quadri e dirigenti, li stimava in circa 570 mila sempre nel 2019: con una crescita del 20% rispetto ai 480 mila dell’anno precedente”.
"Anche gli addetti alla produzione in manifattura possono usufruire di forme smart di lavoro, ad esempio con una maggiore autonomia nella gestione dei propri orari"
Oggi invece si citano spesso cifre come quella di 8 milioni di persone coinvolte…
“Quantificarle in modo preciso è difficilissimo, ci sono però alcuni dati. Il Ministero della Funzione Pubblica stima ad esempio una diffusione dell’80% nell’amministrazione centrale, del 60% nelle Regioni. Il nostro Osservatorio, sempre prima dell’emergenza, aveva stimato in 8 milioni i lavoratori che potenzialmente avrebbero potuto passare allo Smart Working. Tra i settori, i primi a partire sono stati servizi e finance, ovvero banche e assicurazioni, mentre la manifattura è rimasta in parte esclusa, a livello di produzione. Non è detto però che in futuro, grazie allo sviluppo di macchine sempre più sofisticate, anche gli addetti alla produzione possono scegliere forme di Smart Working diverse, e usufruire ad esempio di una maggiore autonomia nella gestione dei propri orari senza dover ricorrere al lavoro da casa”.
In questo quadro, quali cambiamenti a lungo termine nel mondo del lavoro potrà portare l’emergenza che stiamo vivendo?
“La novità è che, una volta costretti al lavoro da remoto, anche chi era scettico sulla possibilità che lo Smart Working si adattasse alla propria realtà aziendale ha potuto verificare che non incide sulla continuità del business, né sulla produttività. Stiamo assistendo insomma a quel cambio di mentalità che rappresenta il primo passo verso un’evoluzione del mercato del lavoro”.
Ecco, la produttività: che riscontri avete avuto su questo punto nelle vostre rilevazioni?
“Uno degli aspetti fondamentali dello Smart Working è proprio quello di misurare i risultati prima e dopo l’attivazione del lavoro agile. Alla voce produttività, le aziende stesse ci hanno segnalato un aumento del 15-20%: un dato frutto sia delle autovalutazioni degli smart worker, sia delle valutazioni dei loro dirigenti in base a una serie di indicatori”.
"Nella nostra ultima rilevazione con lo Smart Working la produttività delle aziende coinvolte è aumentata dal 15-20%"
Lei parlava di un primo passo: quali altri sono necessari per una più ampia diffusione dello Smart Working?
“Ne vedo tre. Occorre una formazione specifica, non solo dei lavoratori coinvolti ma dei manager con cui si rapportano. Servono anche dotazioni tecnologiche, che non sono scontate: gli smart worker devono poter accedere, in completa sicurezza, agli applicativi aziendali. Infine, è necessario sottolineare e far conoscere gli aspetti positivi dello Smart Working per il benessere dei lavoratori: le criticità del lavoro da remoto a cui assistiamo oggi - stress, senso di isolamento, il lavoro che magari tende a prolungarsi oltre l’orario settimanale prima osservato in azienda - non sono proprie di un ‘vero’ Smart Working”.
Come si posizionava l’Italia rispetto ad altri Paesi UE prima dell’emergenza Covid-19 e come pensa che si posizionerà dopo questa crisi?
“Difficile fare paragoni, perché è difficile trovare all’estero lo Smart Working di cui ho parlato, cioè una piena flessibilità nella scelta della sede e degli orari di lavoro e un focus sui risultati. La Finlandia, per fare un esempio, punta sulla flessibilità degli spazi di lavoro e degli orari ma non prevede un esplicito riferimento alla responsabilizzazione delle persone. In questo senso, la legge del 2017 che in Italia regola lo Smart Working è tra le più evolute e mature: altrove il lavoro agile rimane una questione di welfare, da noi investe direttamente la produttività. E si diffonde rapidamente. C’è insomma la concreta possibilità di uscire da quest’emergenza facendo un altro passo verso un’organizzazione del lavoro diversa, con vantaggi sia per le aziende sia per i lavoratori”.
Vuoi essere sempre aggiornato?
Partecipa attivamente, accedi a Open Innovation