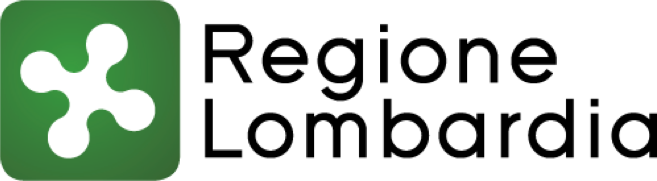Dal Nord Europa alla campagna senese, passando per Londra: Agnes Allansdottir, islandese di nascita e italiana d’adozione da oltre vent’anni, è una dei dieci esperti chiamati da Regione Lombardia a dare vita al nuovo Foro regionale per l’innovazione e la ricerca scientifica. Psicologa sociale, esperta di Social Studies of Science and Technology e di Citizen’s deliberation and public partecipation, Allansdottir ha fatto parte di gruppi selezionati dalla Commissione europea per monitoraggi dell’opinione pubblica sull’impatto di tecnologie e tecnoscienze. In Italia ha insegnato per anni psicologia della comunicazione e comunicazione della scienza all’Università degli Studi di Siena, oltre a collaborare con la Fondazione Toscana Life Sciences nell’ambito della ricerca e dell’innovazione tra pubblico e privato.
Allansdottir, qual è stata la sua formazione?
“Dopo il liceo sono andata in Francia, ero ‘destinata’ a frequentare medicina ma lì ho scoperto la psicologia e tornata in Islanda mi sono laureata in Psicologia sociale. In seguito ho frequentato un dottorato, sempre in Psicologia Sociale, alla London School of Economics and Political Science: proprio a Londra ho preso parte ai primi progetti di ricerca su scienza e società, agli inizi degli anni ’90.Abbiamo iniziato monitorando l’opinione pubblica con sondaggi e analisi sistematiche dei mass media, in vari contesti culturali, su quelle che allora erano tecnologie emergenti ovvero biotecnologie e ingegneria genetica – da lì a poco sarebbero esplose controversie come quelle sugli Ogm o sulla clonazione -, definite dalla Commissione Ue ‘tecnologie potenzialmente sensibili per la società’. Questo mi ha permesso di entrare in un network di ricercatori, che ho portato con me quando mi sono trasferita nella campagna senese. Nel ’96 infatti ho iniziato a lavorare con l’università di Siena, dove ho portato avanti una serie di progetti di ricerca e tenuto corsi universitari interfacoltà sul rapporto tra scienza e società, indagato sempre dal punto di vista della Psicologia sociale, e sull’etica della scienza. In anni più recenti ho rinforzato la mia attività di ricerca internazionale: ad esempio sono stata referente per la Fondazione Toscana Life Sciences (uno dei due partner italiani, l’altro era la Sissa di Trieste) del progetto NERRI (Neuro-Enhancement Responsible Research and Innovation). Finanziato dalla Commissione Europea e partito nel 2013, NERRI aveva l’obiettivo di contribuire a introdurre innovazione e ricerca responsabile nell’ambito di quello che potremmo tradurre come ‘potenziamento cognitivo’, a partire dall’elaborazione di una cornice normativa per regolamentare lo sviluppo di tecnologie in questo settore. Per farlo, dovevamo creare occasioni di scambio, di Mobilitazione e di Mutual Learning tra attori diversi: comunità scientifica, policy maker, industria, gruppi della società civile, associazioni di pazienti e opinione pubblica”.
Dunque il potenziamento delle funzioni cerebrali come tema ‘sensibile’. Ci spiega di cosa si tratta?
“Come alcuni sostengono, il cervello è l’ultima frontiera della scienza: siamo riusciti a mandare degli uomini sulla Luna ma ancora non possiamo dire di conoscere completamente i meccanismi di funzionamento cerebrale. Negli ultimi dieci-quindici anni sono state finanziate molte ricerche sul sistema cerebrale con applicazioni importanti e l’apertura di nuovi orizzonti in campo medico – terapie innovative, strumenti di riabilitazione -, farmacologico e psichiatrico (solo in Europa nel 2014 erano 164 milioni le persone sofferenti per disturbi mentali, ndr). Il nostro compito con NERRI era quello di instaurare un dialogo sensato con la società, per evitare di dare false speranze e per impostare un dibattito corretto sulle potenzialità del neuro enhancement, ovvero della branca delle neuroscienze che si occupa dello sviluppo di strumenti chimici o meccanici per il potenziamento delle capacità mentali dell’individuo: dunque di come migliorare memoria, attenzione e resistenza alla stanchezza grazie a farmaci o a stimolazioni elettromagnetiche, con applicazioni dall’ambito medico a quello militare. Tra gli obiettivi c’era anche quello di classificare le varie tecnologie di neuro-valorizzazione disponibili e di discutere delle implicazioni etico-sociali di questi strumenti, come base appunto a una loro regolamentazione. Da questo punto di vista, l’Italia è stata all’avanguardia, dato che già nel 2013 il Comitato nazionale di Bioetica ha pubblicato due pareri, uno sul potenziamento cognitivo in ambito generale e uno sul suo utilizzo in ambito militare: il Comitato nazionale di bioetica francese, per fare un esempio, solo un anno e mezzo dopo ha pubblicato delle proprie linee guida molto simili a quelle italiane”.
Che reazioni avete registrato allora nelle vostre interviste nei diversi paesi Ue?
“Su alcuni punti sono state simili, su altri anche molto diverse. In Italia ad esempio abbiamo trovato un certo scetticismo soprattutto sul ricorso ai farmaci, che certo qui è più cauto rispetto a quanto accade negli Stati Uniti dove è maggiormente accettato a livello sociale oltre che più ‘diretto’ – nel caso di disturbi dell’attenzione, per dire, basta rivolgersi all’infermiere della scuola. Un’altra differenza emersa con forza riguarda il valore attribuito dalle diverse culture alla competizione: in Austria e in Germania gli interpellati hanno collegato le tecniche di potenziamento cognitivo proprio alla competizione sociale tra individui e respinto un modello di società in cui questa risulti centrale come invece succede, a loro dire, nella cultura anglosassone. Al di là della fondatezza o meno di queste opinioni, la ‘lettura’ che davano degli strumenti di potenziamento cognitivo era dunque questa. E ancora, una delle obiezioni avanzate in molti Paesi era quella sull’opportunità di concentrare risorse sul potenziamento delle facoltà cognitive in individui sani, piuttosto che in persone malate. In tutti i Paesi poi abbiamo riscontrato due diverse visioni: una che delegava allo Stato il compito di tracciare linee di demarcazione tra i farmaci e i trattamenti leciti e quelli non ammessi, e una, che potremmo definire ‘liberal’, secondo la quale ogni individuo ha diritto di decidere della propria vita e del proprio corpo, dunque anche se prendere farmaci o fare quello che serve per aumentare le proprie capacità sensoriali, purché paghi di tasca propria i trattamenti necessari. C’è stato però un punto su cui abbiamo registrato una convergenza pressoché unanime: questa libertà non può valere per i minori o per chi non sia in pieno possesso delle proprie facoltà mentali. Un’affermazione che non investe il semplice uso inappropriato di farmaci, ma chiama in causa il nodo dei confini che si possono porre alla ricerca scientifica. Il punto è allora questo: il compito degli esperti non deve essere discutere per bloccare piuttosto che per promuovere qualche tecnologia, ma cercare di monitorare l’impatto delle diverse tecnologie e su questo avviare un dialogo responsabile”.
Nella sua lunga esperienza di ricerca di psicologia sociale su questi temi, cosa è cambiato negli anni nel rapporto tra comunità scientifica e opinione pubblica?
“Un cambiamento c’è stato: ovunque abbiamo visto crescere la diffidenza nelle istituzioni, anche se bisogna specificare che questa sfiducia non si riversa sulla sola scienza ma investe l’intero sistema delle nostre società, dalla politica alle banche. E non solo in Italia, dove pure questa diffidenza si è manifestata in modo evidente, tempo fa, con alcune campagne contro i vaccini. Penso però che questa possa essere una straordinaria opportunità per una riflessione collettiva sul valore delle scienze. La diffidenza diffusa di cui dicevo si accompagna infatti a una grande fiducia nelle potenzialità dell’innovazione, se riscontriamoperplessità queste riguardano piuttosto la gestione dell’innovazione. C’è dunque spazio per un rinnovato dialogo tra la comunità scientifica, innovatori e cittadini”.
In questo contesto, che ruolo pensa possa svolgere il neonato Foro lombardo?
“Sono molto fiera e molto onorata di far parte di questo esperimento: mi sembra veramente opportuno e mi sembra il momento giusto per individuare, sviluppare e consolidare forme di dialogo in grado di coinvolgere tutta la cittadinanza nella costruzione orizzonti condivisi di innovazione scientifica e tecnologica. Soprattutto ora che in Europa sono in vista diversi cambiamenti nei criteri di assegnazione dei fondi per progetti di ricerca, quello di Regione Lombardia mi pare un passo avanti importante per l’Italia, dove non abbiamo una tradizione di Technology Assessment come quella di altri paesi Ue”.